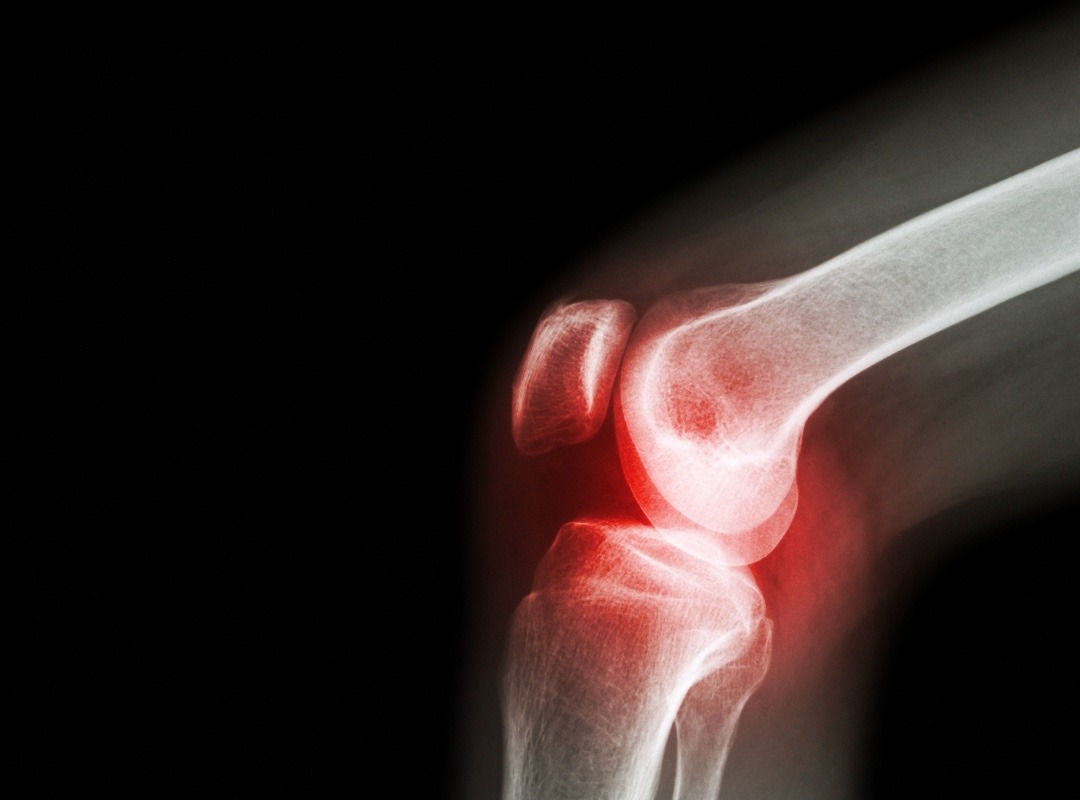La bronchiolite è un'infezione virale acuta, che va ad intaccare il sistema respiratorio, in particolare quello dei bambini di età inferiore ad un anno. La patologia si manifesta con più incidenza nei primi 6 mesi di vita e ha maggiore incidenza tra novembre e marzo. A causare la patologia, generalmente nel 75% dei casi, è il virus respiratorio sinciziale (VRS).
Tuttavia anche altri virus possono colpire l'apparato dei bambini, come, ad esempio, il metapneumovirus, coronavirus, rinovirus, adenovirus, virus influenzali e parainfluenzali. L'infezione è secondaria a una trasmissione che avviene primariamente per contatto diretto con le secrezioni infette.
La fase di contagio dura tipicamente da 6 a 10 giorni. Il virus attacca principalmente i bronchi e i bronchioli, causando un processo infiammatorio, che porta all'aumento della produzione di muco e all'ostruzione delle vie aeree con possibile comparsa di difficoltà respiratoria.
Indice
- I sintomi della bronchiolite
- Le cause
- La diagnosi
- Come prevenire la bronchiolite
- Il trattamento per la bronchiolite
I sintomi della bronchiolite
La bronchiolite nei più piccoli si manifesta generalmente con stati febbrili e rinite, cioè un'infiammazione nasale. In seguito possono comparire tosse insistente, che può diventare acuta, difficoltà legate alla respirazione, che possono essere caratterizzate da un aumento della frequenza respiratoria e da rientramenti intercostali. Nella maggior parte dei casi la bronchiolite si risolve da sola, senza gravi conseguenze.
Le cause
I fattori che possono aumentare il rischio di bronchiolite e che la patologia si aggravi sono la prematurità, l'età del bambino (< 12 settimane), cardiopatie congenite, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica, le anomalie congenite delle vie aeree e le immunodeficienze.
La diagnosi
La diagnosi di bronchiolite è di tipo clinico. Il pediatra valuta l'andamento dei sintomi e prescrive la cura. Solo in casi particolari, possono essere effettuati alcuni accertamenti di laboratorio e/o strumentali come, ad esempio, la ricerca dei virus respiratori sull'aspirato nasofaringeo, la determinazione dell'ossigenazione tramite saturimetro e l'emogasanalisi arteriosa, cioè un esame che valuta l'ossigenazione del sangue. In alcuni casi anche tramite la misurazione dell'anidride carbonica e l'efficacia degli scambi gassosi.
Raramente è richiesta la radiografia del torace nel caso di eventuali addensamenti di muco e aree di assenza di aria in più zone dei polmoni, a causa della ventilazione alterata.
Come prevenire la bronchiolite
Di solito bastano alcune semplice regole di igiene quotidiano per ridurre il pericolo di contrarre la bronchiolite o per evitare infezioni correlate, che possono peggiorare il quadro clinico.
È sempre importante:
- evitare il contatto dei bambini più piccoli con altri coetanei o con adulti affetti da infezioni delle vie aeree;
- lavarsi sempre le mani prima e dopo aver accudito il bambino;
- favorire l'allattamento al seno;
- effettuare lavaggi nasali con soluzione fisiologica o ipertonica;
- non fumare mai davanti al bambino e anche in ambiente diversi dove al momento non si trova.
Il trattamento per la bronchiolite
Il paziente con bronchiolite deve fare frequenti lavaggi nasali con aspirazione del muco e sottoporsi a terapia aerosolica con soluzione ipertonica al 3%. Questa serve al bambino per mobilizzare le abbondanti secrezioni mucose catarrali. Nei casi più gravi o se la bronchiolite persiste, può essere prescritta la somministrazione di cortisone per bocca. Anche se la più recente letteratura scientifica non dimostra che i bambini sottoposti a questa terapia vadano incontro ad un miglioramento. L'uso di antibiotici è fortemente sconsigliato.
Quando è necessario il ricovero?
Quando la bronchiolite diventa acuta, può rendersi necessario il ricovero ospedaliero, specialmente al di sotto dei sei mesi di vita. Nei neonati di questi mesi è spesso presente un calo dei livelli di saturimetria, cioè di ossigeno nel sangue, e può verificarsi una disidratazione causata proprio dalla difficoltà di alimentazione e dell'aumentata perdita idrica determinata dal lavoro respiratorio.
Inoltre, nei nati prematuri o di età inferiore alle 6 settimane di vita, aumenta di più il rischio di apnea. L'episodio di pausa respiratoria prolungata va tenuto sotto controllo, valutandone i parametri cardio-respiratori. Generalmente la malattia è benigna e si risolve spontaneamente in circa 12 giorni.